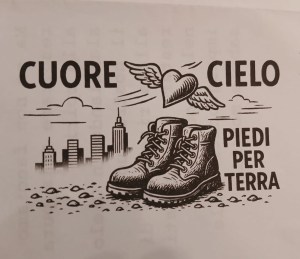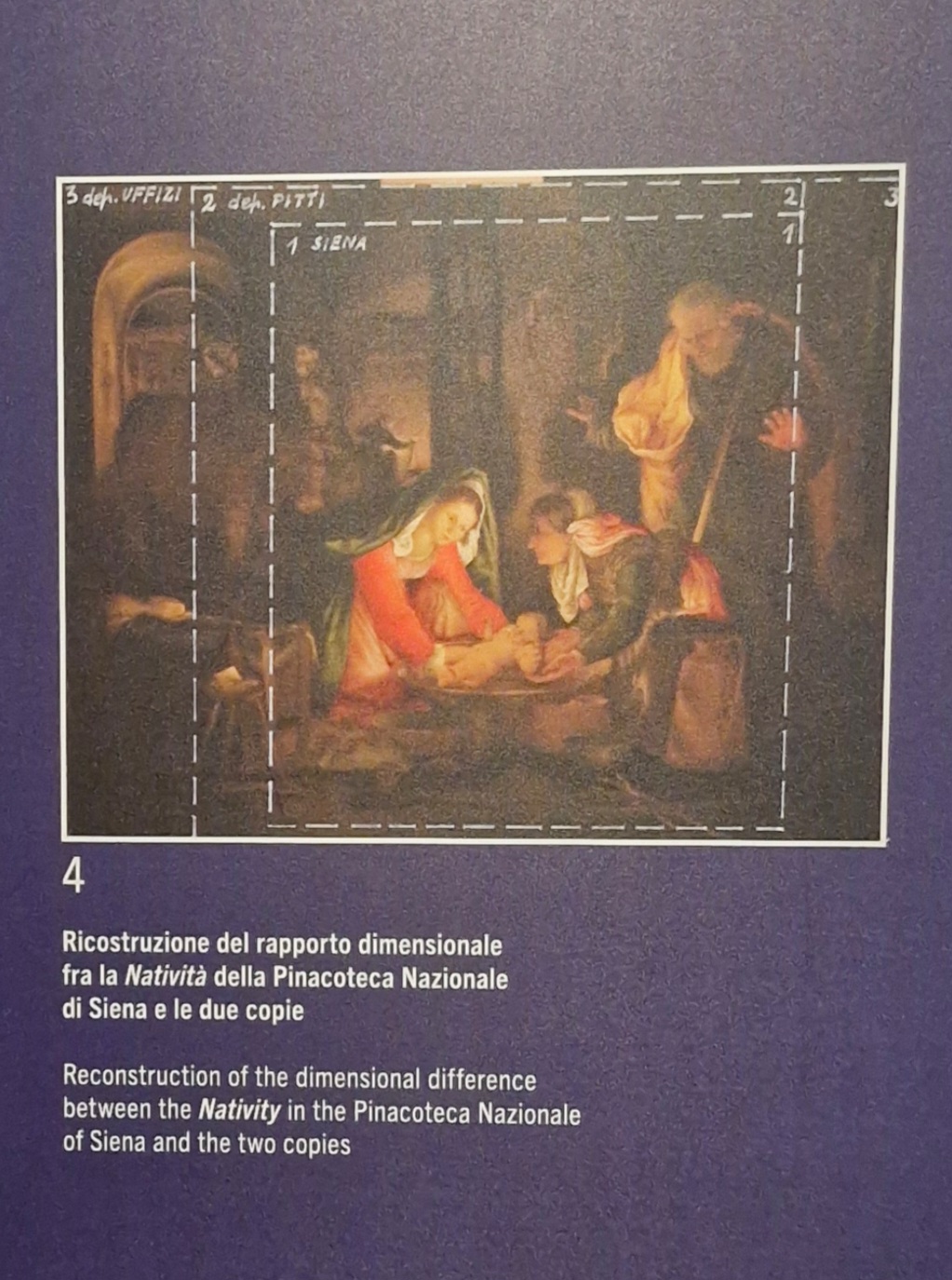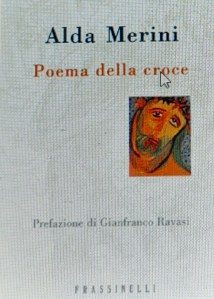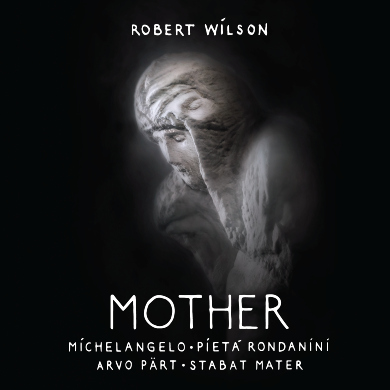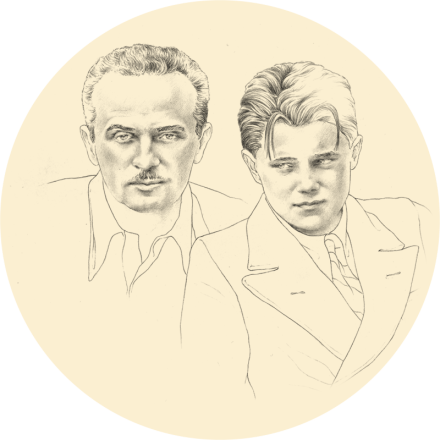La storia dei Giochi Olimpici, vista attraverso le opere di grande pregio raccolte per la mostra in corso alla Fondazione Rovati, prosegue facendoci letteralmente entrare nella “Tomba delle Olimpiadi” (530-520 a.C.) proveniente dal Museo Archeologico di Tarquinia. Alle pareti non riproduzioni, ma dei dipinti a secco, strappati e riposizionati su tela, che escono per la prima volta dalla loro sede per essere ospitati in questo museo di arte etrusca.
Siamo circondati, diremo quasi avvolti, da immagini di gare di corsa, lancio del disco, incontri di lotta e pugilato, corse di bighe e da raffigurazioni di danze e banchetti. Colpisce, di fronte all’ingresso, la porta che segna il passaggio per l’aldilà; è un’immagine di grande impatto emotivo: di qui la vita con i suoi piaceri, oltre la porta il mistero di ciò che non si conosce.
In un’altra sala, molto interessante è la copia, realizzata nell’Ottocento da Carlo Ruspi e proveniente dei Musei Vaticani, delle pitture murali etrusche relative alla “Tomba delle bighe”. Anche qui giovani che danzano o suonano, gare sportive, un tavolo per il banchetto e alcune bighe con auriga.
In alto, una tribuna coperta ospita gli spettatori. Anche questa tomba è un inno alla vita che ci testimonia come le gare facessero parte dei piaceri terreni e dei rituali funebri; quasi un invito al Carpe diem?
Gli antichi Romani, anche dopo la conquista dell’Ellade, non “adottarono” mai veramente le Olimpiadi. I giochi preferiti erano per lo più spettacoli popolari con corse di bighe e quadrighe, combattimenti tra gladiatori o contro animali.
Uno di questi gladiatori, storico e non hollywoodiano, è Urbicus, un secutur, la cui stele funeraria si trova a Milano, all’Antiquarium “Alda Levi” di via De Amicis. Questa lapide ci riporta all’amore della sua famiglia che ricorda un atleta ucciso a tradimento dopo un combattimento vittorioso.
I giochi al tempo dei Romani divennero quasi un “rito”, un ammortizzatore sociale e politico: panem et circenses. Paradossalmente chi amò le Olimpiadi fu un Imperatore molto controverso: Nerone. Infatti gareggiò ad Olimpia come atleta e artista, vincendo (?!!!) oltre 1800 gare, facendo persino spostare la data delle Olimpiadi. Il suo trionfo a Roma fu grandioso e i suoi trofei furono portati in corteo. A lui accostiamo un’immagine della mostra, il trofeo opera di Peter Carl Fabergè, realizzato per conto dello Zar Nicola II come premio per il vincitore di una gara.
Via via il fuoco della fiaccola olimpica si affievolì sempre più, tanto che l’Imperatore Teodosio, nel 393 d.C. lo fece spegnere, abolendo i Giochi insieme ad altri riti pagani. Ci furono secoli di oblio, ma, come il leggendario fiume Alfeo che attraversa la piana di Olimpia, scorre poi sottoterra e riemerge, per volere di Zeus, nell’isola di Ortigia (a Siracusa) per ricongiungersi con l’amata Aretusa, così i Giochi Olimpici rinacquero a fine Ottocento per merito del barone Pierre De Coubertin.
La prima Olimpiade moderna si tenne ad Atene nel 1896. Poi, come un tempo, i Giochi attraversarono momenti storici diversi e difficili: guerre, boicottaggi politici, attentati, persino il Covid, che fece rimandare di un anno i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Lo sport olimpico si urbanizzò e divenne “mondiale”. Si aggiunsero gare, discipline sportive nuove e, persino, altri Giochi, quelli Invernali e quelli Paralimpici.
Ora tocca a Milano-Cortina! “Altius, Fortius, Citius et… Communiter”
A presto…